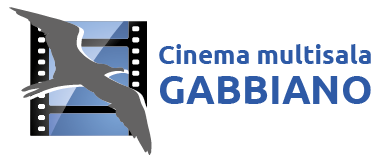Nella preghiera della Colletta, prima di presentare a Dio Padre la nostra richiesta, abbiamo riconosciuto che lui “in (con, grazie a) Cristo buon pastore si prende cura delle nostre infermità”.
L’infermità è l’esito devastante prodotto da una malattia su di noi, sulla nostra persona, che si ripercuote sulla nostra esistenza e su quella degli altri. Spesso si tratta di un’infermità irreversibile, permanente.
Tra le tante infermità che da tempo ci affliggono, una appare particolarmente grave, difficile da superare: non riusciamo più ad ascoltarci con fiducia, a riconoscerci partecipi di un’umanità che non può essere “disonorata”, per nessuna ragione e in nessuna circostanza. Ci sentiamo come un gregge disperso, che non ha più chi lo tiene unito, lo protegge dall’aggressione del lupo dell’intolleranza che genera conflitti, crea nemici da cui difenderci.
Si tratta di un’infermità che appare invincibile e alla quale rischiamo di arrenderci. Nemmeno la comune sofferenza prodotta su larga scala dalla pandemia sembra in grado di guarirci da questa infermità: le notizie che provengono dal versante dell’azione sanitaria, dell’azione politica e dei comportamenti individuali, confermano l’inclinazione a procedere in ordine sparso, la fatica di prestarci ascolto, di farci carico gli uni degli altri, in particolare dei più fragili, dei più esposti agli effetti devastanti della pandemia.
Gesù nel vangelo di questa quarta domenica di Pasqua (Gv 10,11-18) si presenta come “il buon pastore”, il pastore affidabile, perché, a differenza del mercenario che non comunica con le pecore, non contrasta l’aggressione mortale del lupo («il mercenario…vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde»), lui comunica con le pecore, le raduna, le tiene unite in “un solo gregge”.
Il mercenario non le tiene unite perché le pecore non gli stanno a cuore (“non gli importa delle pecore”), Gesù, invece, le tiene unite perché le pecore gli stanno a cuore, fino al punto di decidere di “dare la propria vita per le pecore” («Io do la mia vita…Nessuno me la toglie: io la do da me stesso»).
Per questa ragione le pecore lo riconoscono come pastore buono, affidabile, “ascoltano la sua voce”, si lasciano guidare, radunare da lui in un solo gregge.
Quanto Gesù dice di sé nel vangelo («io sono il buon pastore»), di noi (le pecore che gli stanno a cuore, di cui lui si prende cura) e di come lui si mette in gioco per noi («il buon pastore dà la vita per le pecore») ci incoraggia ad avanzare la nostra richiesta a Dio Padre: «donaci di ascoltare oggi la sua voce, perché, riuniti in un solo gregge, gustiamo la gioia di essere tuoi figli».
La richiesta attesta la nostra fiducia in Gesù, “il buon pastore”, perché, a differenza dei tenti “mercenari” che in questi tempi così dolorosi presumono, con le loro opinioni, le loro letture della situazione e le loro ricette (amplificate e proposte con invadenza dai tanti mezzi della comunicazione) di guarirci dalle infermità che ci affliggono, lui non aggredisce con le sue parole, non alimenta scontri di opinione, ma parla con discrezione al cuore delle persone. A differenza dei “mercenari”, che non conoscono la nostra vita, le nostre infermità e ai quali stanno a cuore il riconoscimento pubblico delle proprie opinioni, la stima delle persone, Gesù ci conosce personalmente, a lui stiamo a cuore, sta a cuore che non continuiamo a vagare come un gregge senza pastore, esposto all’aggressione del “lupo” della paura che provoca intolleranza, chiusura, che divide, disperde.
Perché allora, dopo aver chiesto a Dio Padre di aiutarci ad ascoltare la voce di suo Figlio, “pastore buono”, affidabile, perché “ha deposto” la sua vita per noi, non deciderci a privilegiare l’ascolto della sua parola, rispetto alle parole dei tanti mercenari, nella fondata speranza di guarire dalle tante infermità che ci affliggono e ci disperdono?