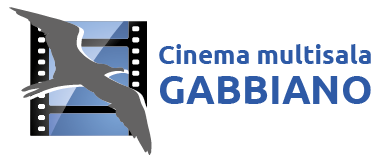L’apostolo Paolo (cfr 2a lettura, 2Tm 4,6-8.16-18), un pubblicano e un fariseo (cfr vangelo, Lc 18,9-14): modi diversi di guardare alla propria vita, di stare di fronte al Signore. Paolo e il fariseo fanno un racconto positivo: il fariseo di se stesso, del proprio comportamento, Paolo del proprio ministero, del proprio passato e del proprio futuro.
A dividerli è il ruolo riconosciuto al Signore nella loro vita. L’Apostolo riconosce che il Signore gli è stato vicino, che gli ha dato forza per portare a compimento l’annuncio del vangelo e che questa vicinanza proseguirà in futuro, con la liberazione dal male (“mi libererà da ogni male”) e con la condivisone della sua vita di Risorto (“mi porterà nel suo regno”).
Il riconoscimento della vicinanza del Signore dà serenità a Paolo, il quale non usa parole di biasimo contro chi lo ha lasciato solo proprio nel momento del massimo bisogno (“in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto”) e guarda al proprio futuro, che si prospetta di morte, con la fiducia di chi non si sente abbandonato da Colui per il quale ha impegnato la propria vita.
Il fariseo si comporta diversamente. A segnalarlo è la sua preghiera, nella quale sono presenti due limiti. Il primo è dato dal fatto che il fariseo si sente autosufficiente, privo del desiderio di essere custodito da Dio, il quale non lo può innalzare a sé, perché quest’uomo si sente già in alto, non si riconosce bisognoso del suo perdono. Dopo l’iniziale ringraziamento (“O Dio, ti ringrazio…”), che fa ben sperare, il fariseo prosegue la propria preghiera parlando solo di sé, elogiando se stesso e dicendo male degli altri, pubblicano compreso (“non sono come gli altri uomini…neppure come questo pubblicano”).
Il secondo, che appare un’aggravante del primo, è che la presunzione della propria giustizia alimenta il disprezzo degli altri, del loro non essere all’altezza di Dio.
Al fariseo Gesù preferisce il pubblicano, con il suo atteggiamento dimesso («fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto»). La sua preghiera è molto più breve di quella del fariseo: introdotta dal vocativo («O Dio»), è seguita dalla richiesta («abbi pietà di me peccatore»). Il commento di Gesù mette a confronto l’azione di Dio verso i due protagonisti («Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato»). La nuova situazione, capovolta rispetto a quella presentata nella parabola, è spiegata con un commento finale: «Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
I limiti della preghiera del fariseo ci devono far riflettere, perché possono essere anche i nostri. Non si tratta di attribuirci colpe che non abbiamo o d’inventare peccati non commessi, nemmeno di non riconoscere il bene da noi compiuto. Si tratta invece di saper riconoscere l’azione di Dio nella nostra esistenza perché ci resta vicino nelle vicende della vita, anche in quelle che ci hanno messo alla prova, ci ha custodito e continua a custodirci (come ha fatto l’apostolo Paolo) e di supplicarlo quando riconosciamo di esserci allontanati da Lui (come ha fatto il pubblicano). E’ proprio quanto abbiamo chiesto nella Colletta: «fa che ci apriamo alla confidenza nella tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome», rassicurati dal Siracide, per il quale “la preghiera del povero arriva fino all’Altissimo” (cfr 1a lettura, Sir 35,15b-17.20-22a).